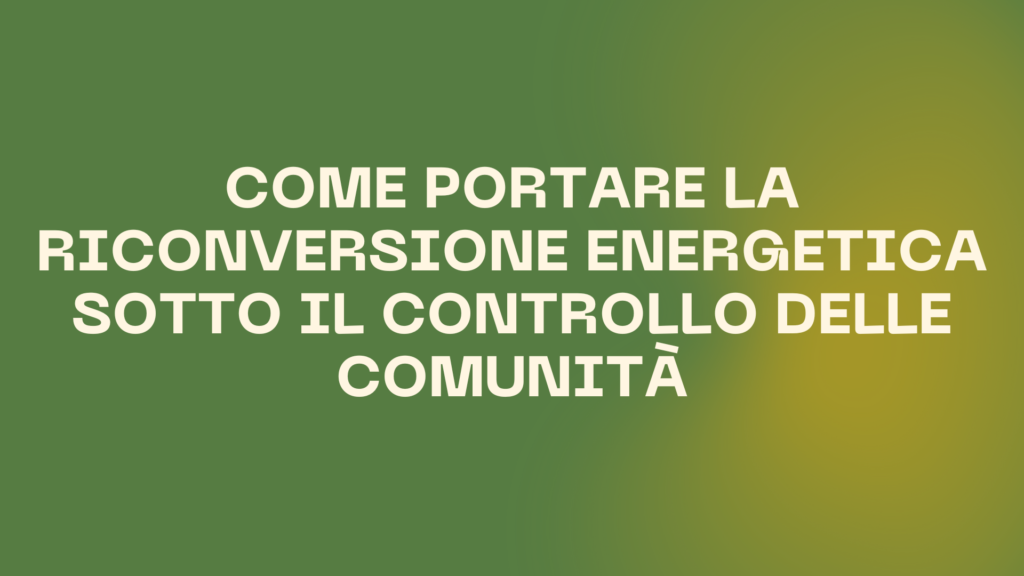Lanciamo questa prima riflessione come primo passo per allargare la riflessione intorno al possibile utilizzo delle Comunità Energetiche. L’obiettivo è cominciare a delineare una varietà di modelli per rilanciare la riconversione ecologica dal basso
Introduzione
I concetti di democrazia energetica e di beni comuni sono alla base di qualsiasi transizione ecologica che sia giusta e partecipata dal basso.
Le comunità energetiche rinnovabili si sono subito presentate come lo strumento ideale per instradare la transizione energetica sul giusto binario, dal momento che uniscono lo sviluppo delle energie pulite con il coinvolgimento delle comunità locali. Tuttavia, la nascita di comunità energetiche negli ultimi anni è stata molto più lenta di quanto sperato.
I motivi sono diversi e hanno a che fare da una parte con i ritardi nell’emissione dei decreti ministeriali e con la pesante e farraginosa burocrazia necessaria per creare una comunità energetica, ma dall’altra anche con l’ostacolo posto dall’investimento iniziale, che in molti casi non è alla portata delle comunità.
Le comunità energetiche rischiano, di questo passo, di avere un ruolo molto marginale nello scenario delle energie rinnovabili, visto che le poche nate finora sono anche di piccola taglia, lontano dagli ordini di grandezza della nuova potenza che sarebbe necessario installare, in particolare nei comuni sopra 5.000 abitanti in cui gli incentivi sono ridotti (si vedano le FAQ pubblicate sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. 12)
In questo documento raccogliamo alcune proposte per rendere più efficace lo strumento delle comunità energetiche e per rendere più decisivo il contributo delle comunità nella gestione dell’energia.
Ci concentriamo sul concetto di comunità per rimandare a un insieme di valori e modelli che possono ricadere nella categoria di “comunitari”, cioè che intendono proporre una nuova idea di democrazia fatta di nuovi corpi intermedi locali che si occupino di gestire beni pubblici senza fini di lucro. Questa modalità di gestione può evitare di incappare nelle ambiguità e nei problemi di modelli esclusivamente pubblici o privati, cercando invece una diversa via legata a doppio filo ai beni comuni.
In tal modo lo Stato guadagna importanti alleati sui territori in grado di concretizzare la democrazia stessa rendendola una pratica quotidiana al di là dell’ambito istituzionale.
Gli accordi pubblico-comunità
Gli accordi pubblico-comunità, in breve APC (traduzione libera dell’inglese Public-common partnership) sono un modello in cui le comunità organizzate collaborano con enti pubblici per farsi assegnare la gestione di risorse come edifici, aree naturali o, appunto, impianti di produzione di energia. Il modello si articola solitamente in questo modo:
- Viene creata un’impresa collettiva, in breve IC (in inglese Joint enterprise)
- L’impresa è posseduta e condotta in maniera condivisa da un ente locale, dai suoi impiegati, e da un’associazione che rappresenti la comunità
- Un consiglio di amministrazione dell’IC costituito per un terzo da rappresentanti dell’ente comunale o regionale, per un terzo da rappresentanti dell’ente comunitario e per un terzo da rappresentanti di un insieme di enti pubblici (università, agenzie) e non (sindacati, enti terzo settore) che possono collaborare attivamente con le attività dell’IC.
- La conduzione e l’azione dell’impresa sono definite da un regolamento che ne determina gli obiettivi sociali ed ecologici
- L’ente pubblico trasferisce in concessione o gestione risorse e beni pubblici all’impresa, vincolando il loro uso al rispetto del regolamento, e continua a sostenere i costi della loro manutenzione, assicurazione, ecc., giustificando tali spese con il riconoscimento del valore sociale della gestione comunitaria di questi beni.
- Il profitto dell’impresa in parte è ritenuto e in parte trasferito all’associazione comunitaria, che decide come investirlo in base agli obiettivi dell’impresa. In particolare questi profitti possono essere usati per creare nuovi accordi pubblico-comunità.
Il caso delle comunità energetiche
Nel caso delle comunità energetiche (in breve CER, a cui spesso viene aggiunta la S di solidale), ecco come immaginiamo l’applicazione di questo modello:
- I membri della comunità formano una prima associazione comunitaria (AC) per preparare la formazione della impresa collettiva (IC).
- La AC comincia a coinvolgere la popolazione del territorio su cui prevede di lavorare, identificando gli edifici e i terreni in cui potrebbero sorgere gli impianti e parlando con tutti i soggetti che potrebbero esserne influenzati: gli stakeholder, cioè i portatori di interesse, e i rightholder, cioè chi possiede i terreni o gli edifici in questione. Ad esempio, nel caso del tetto di un edificio pubblico, la AC coinvolge chi utilizza quell’edificio (studenti, docenti e genitori nel caso di una scuola; lavoratrici e lavoratori nel caso di un ufficio, ecc.). Nel caso di un terreno agricolo, coinvolge chi attualmente utilizza quel terreno e le imprese presenti nei terreni circostanti.
In questo modo l’AC costruisce una mappatura dei luoghi in cui potrebbero sorgere impianti, ottenendo da una parte una prima stima dei fondi e dei terreni necessari all’iniizio, dall’altra stabilendo un primo contatto con il territorio e individuando i conflitti da risolvere. - Due possibili modelli di consultazione sono l’assemblea popolare e l’assemblea cittadina.
- Un’assemblea popolare porta i rightholder e gli stakeholder a consultarsi con la popolazione locale in una serie di riunioni informali. La partecipazione è su base volontaria, ma la AC può cercare di coinvolgere attivamente fasce della popolazione a priori poco interessate a partecipare.
- Un’assemblea cittadina porta a consultarsi un campione statistico di cittadini e cittadine estratte a sorte, che ascoltano prima il parere degli esperti e dei rightholder e stakeholder, e poi discutono autonomamente della questione, in maniera facilitata. La partecipazione deve essere remunerata e deve garantire la possibilità di assentarsi dal lavoro, con l’ente locale che sostiene i costi di compensazione.
Il modello migliore da adottare può variare in base alla situazione, alla buona disposizione dell’ente locale e alle risorse economiche e temporali disponibili. Un’assemblea popolare è in generale più rapida ed economica, e si può svolgere anche prima di aver ottenuto il supporto dell’ente locale.
- Contestualmente, la AC comincia un processo di dialogo con le istituzioni pubbliche comunali o regionali che preveda l’istituzione di un regolamento per l’assegnazione delle superfici pubbliche a IC, come quello recentemente approvato dal comune di Roma (link).
- L’IC prende la forma di una comunità energetica rinnovabile, costituita dall’AC come società (ad esempio cooperativa).
- Il comune o la regione acquisiscono una quota della IC. Anche nel caso si adotti il modello dell’azionariato diffuso (vedi sotto), complessivamente l’ente locale e l’AC devono detenere in ogni caso la maggioranza assoluta delle azioni.
- Lo statuto della comunità energetica rinnovabile, previsto dalla normativa, definisce i vincoli e gli obiettivi ecologici e sociali.
- Il comune o la regione, attraverso la creazione di una cabina di regia che coordini tutti gli altri enti locali da coinvolgere, trasferiscono alla CER le superfici necessarie alla realizzazione degli impianti, utilizzano soldi pubblici per acquistare gli impianti della CER, e sviluppano gli indicatori per monitorare l’andamento delle IC.
- L’AC e l’IC continuano a coinvolgere le comunità locali all’interno della CER svolgendo un’intensa attività di consultazione territoriale da cui cominciare la pianificazione di nuovi impianti, sia su piccola che larga scala. Data la possibilità di registrare al GSE (gestore servizi energetici) più configurazioni all’interno della stessa CER, l’IC può operare su impianti dislocati in un’area molto vasta, purché nella stessa zona del mercato elettrico.
- L’azione dell’IC viene monitorata tramite rendiconti periodici che rispondano sia alle necessità dell’amministrazione locale (ad esempio dimostrare che i fondi pubblici vengano allocati in maniera appropriata), sia a quelle dell’IC (ad esempio auto-valutare i propri risultati).
Il ruolo dell’azionariato diffuso
L’approccio che proponiamo permette di inserire le comunità energetiche in una strategia scalabile, e non più solo interstiziale, per direzionare la transizione ecologica.
Tuttavia, affinché questo accada, gli investimenti pubblici dovranno essere correlati e adeguati alla copertura delle superfici disponibili e ai target necessari alla decarbonizzazione.
Se gli investimenti pubblici fossero limitati o insufficienti, si può considerare lo strumento dell’azionariato diffuso come formula di co-finanziamento, mantenendo la maggioranza azionaria dell’IC in mano all’ente pubblico e all’associazione comunitaria, ma dividendo le quote restanti fra molti diversi investitori privati.
Questa strategia, che sta già venendo collaudata attraverso la campagna di azionariato popolare del Collettivo di Fabbrica GKN, può anche diventare un modo per coinvolgere una platea di soggetti più grande e diversa all’interno della comunità energetica, aumentando la potenzialità che questa diventi un vero e proprio soggetto aggregatore e che funzioni da corpo intermedio per un grande numero di persone.
Rapporto con le multi-utility
Una misura complementare al modello che proponiamo è la rimunicipalizzazione (cioè il ritorno al controllo pubblico) delle aziende partecipate (in particolare le “multi-utility”). Infatti, nelle aree con densità abitativa medio-bassa, si può arrivare a una situazione in cui la maggior parte dell’energia elettrica per il consumo domestico è generata attraverso impianti gestiti in maniera comunitaria. Nelle aree più densamente abitate, tuttavia, la scalabilità è inferiore e il controllo dell’energia nelle città rimarrebbe in ogni caso nelle mani delle multi-utility, a loro volta controllate da azionisti privati: la democratizzazione dell’energia non sarebbe completa senza una rimunicipalizzazione di queste aziende, preferibilmente modificandone la forma societaria in modo da trasformarle in cooperative controllate anche dai propri dipendenti.
Gli investimenti necessari per la rimunicipalizzazione sono notevoli, ma sono motivati tra le altre cose dal seguente fatto: se le comunità energetiche costituite tramite APC e le aziende partecipate acquisissero complessivamente la maggioranza del mercato energetico, questo permetterebbe di fatto allo Stato di controllare e quindi stabilizzare il prezzo dell’energia. Si potrebbero allora tagliare le costose politiche di derisking (di fatto sussidi alle aziende energetiche) che vengono impiegate oggi per stabilizzare il prezzo dell’energia, e che sono considerate da gran parte degli esperti inefficienti e insufficienti a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (si veda qui)
Ostacoli da superare
- Affinché sia legalmente possibile per un’associazione di cittadini organizzati possedere una quota di un’impresa, potrebbe essere necessario che l’associazione acquisisca un codice fiscale e si costituisca in una forma giuridica rigida, che potrebbe entrare in contrasto con la natura molto fluida e mutevole delle comunità locali, e con i metodi decisionali democratici e orizzontali che l’associazione dovrebbe utilizzare. Tuttavia è possibile formare un unico ente che coinvolga tutti i gruppi informali comunitari presenti nei territori dove opera l’IC.
- Gli enti pubblici possono essere legalmente vincolati a dimostrare che un accordo pubblico-comunità sia la maniera più efficiente o economicamente conveniente per gestire un bene pubblico (in questo caso un terreno o un impianto di produzione di energia elettrica). Gli accordi pubblico-comunità rischiano quindi di avere la peggio quando competono altre opzioni più redditizie da un punto strettamente economico (ad esempio le partnership pubblico-privato). Proprio per questo è fondamentale l’istituzione di un regolamento per l’uso di superfici pubbliche e la creazione di un ente di coordinamento che riconoscano la differenza fra affidamenti a enti privati e enti comunitari.
Glossario:
- Area convenzionale: il territorio italiano è diviso in aree convenzionali. Ogni area convenzionale ha una e una sola cabina primaria (vedi sotto). Affinché possano scambiarsi energia all’interno di una comunità energetica, tutti gli impianti devono trovarsi all’interno della stessa area convenzionale (si vedano le FAQ pubblicate sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. 10). Una mappa è disponibile sul sito del GSE
- Beni comuni: risorse comunitarie percepite come espressione di valori e principi condivisi da una collettività, classificate secondo due criteri (naturalità/artificialità, e materialità/immaterialità) in:
- Beni comuni naturali e materiali (ad es. acqua, boschi)
- Beni comuni artificiali e materiali (ad es. reperti archeologici o opere artistiche)
- Beni comuni naturali e immateriali (ad es. energia, cielo, orbita terrestre)
- Beni comuni artificiali e immateriali (ad es. conoscenza, Rete internet)
- Cabina primaria: impianto elettrico in cui l’energia viene trasformata da alta tensione a media tensione. In Italia ce ne sono circa 2000, sparse sul territorio.
- Comunità energetica rinnovabile (CER): una CER è un ente (si vedano le FAQ pubblicate sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. 4), con uno statuto, un atto costitutivo ecc, con una forma giuridica non specificata, che può essere ad esempio un ente del terzo settore (ETS, APS, ODV, ecc.) oppure una società (Spa, società cooperativa, ecc.). I membri dell’associazione sono detti soci.
- Configurazione (di autoconsumo diffuso): una configurazione è un insieme di produttori e consumatori di energia elettrica che si scambiano tra loro l’energia. Ne esistono 7 tipi (si veda ad esempio il sito del GSE) ma quello che ci interessa è la configurazione di CER
- Configurazione di comunità energetica rinnovabile (o configurazione di CER): è una delle configurazioni di cui sopra, caratterizzata dal fatto che tutti i membri della configurazione si trovano nella stessa area convenzionale (vedi sopra) e che tutti gli impianti della configurazione sono controllati da una stessa CER.
Deve comprendere almeno due soci della CER (di cui un produttore e un consumatore). Una “configurazione di CER” non è una CER: non è un’associazione, non ha uno statuto ecc. Una “configurazione di CER” fa sempre parte di una CER, e una CER può comprendere tante “configurazioni di CER” diverse (Regole operative del GSE, pag. 16), anche in diversi territori! La configurazione è legata al territorio, ma l’associazione no (esempio). - Impianto (di produzione di energia rinnovabile): ad esempio un parco solare; un parco eolico o una singola pala isolata; una diga idroelettrica o turbina per mini-idroelettrico; l’insieme dei pannelli solari montati su uno stesso edificio (per la definizione precisa si vedano le Regole operative del GSE, pag. 9 e pag. 149).
In una comunità energetica, ogni impianto può avere potenza massima di 1MW (= 1000 kW). Invece la potenza massima della comunità energetica può essere grande quanto si vuole: ad esempio se ci sono mille impianti da 1MW la potenza totale sarà di 1GW. E’ anche possibile includere impianti di potenza maggiore di 1MW in una configurazione di CER, ma questi impianti accedono soltanto a uno dei due incentivi per le CER (il minore tra i due), ovvero il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (si vedano le FAQ pubblicate sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. 12; e le Regole operative del GSE, pag. 10) - Impianto esistente: la normativa richiede che le comunità energetiche si compongano principalmente di impianti “nuovi”, cioè realizzati a partire dal 15 dicembre 2021. Tuttavia, una configurazione di CER può contenere anche impianti “esistenti”, a patto che non superino il 30% di potenza complessiva della configurazione. L’energia elettrica immessa in rete da impianti esistenti viene conteggiata ai fini del calcolo dell’energia condivisa. Come per gli impianti sopra 1MW, anche gli impianti esistenti accedono solo al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (si vedano le Regole operative del GSE, pag. 10).
Alcune fonti:
https://www.tni.org/en/publication/reclaiming-energy
https://www.common-wealth.org/interactive/a-new-model
https://www.rosalux.de/en/news/id/51945/transforming-the-public-into-the-commons
What is a Public-Commons Parntership?
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Studien/Pathway-Energy-EU.pdf