
di Amitav Ghosh
OGGI, raramente la parola bruto viene utilizzata come in passato. Nessuno impiega questo aggettivo né per gli animali né, a maggior ragione, per riferirsi a persone o etnie. Nessuno esclama “sei un bruto!” come i personaggi dei romanzi vittoriani fanno in continuazione.
Eppure, nonostante il suo significato originario sia ormai andato perduto nell’uso comune, i suoi derivati, come brutale e brutalità, sono diventati onnipresenti su internet, nei giornali e sugli striscioni che i manifestanti brandiscono per le strade sotto al grido di “Black Lives Matter!” – contro l’abuso di potere della polizia che è, chiaramente, il cuore pulsante delle proteste.
L’attuale ubiquità della parola brutalità rappresenta un ribaltamento straordinario: il suo campo semantico non fa più riferimento al selvaggio o al semi civilizzato; si riferisce invece al meccanismo repressivo dello Stato e, prima ancora, della polizia. Questa inversione di significato crea una parabola etimologica che lega la crisi planetaria direttamente ai processi di colonizzazione, schiavismo e guerra biopolitica.
Con il passare dei giorni – sto scrivendo queste parole verso fine luglio 2020 – emergono, dalla nebbia del passato, sempre più rapporti di correlazione storica che legano, ad esempio, l’attuale violenza della polizia a quella delle pattuglie che presidiavano le piantagioni nel diciottesimo e nel diciannovesimo secolo. Ogni giorno vedo riferimenti al 1619, anno in cui i pirati Inglesi portarono la prima nave carica di schiavi in Virginia. Ogni giorno le notizie parlano di statue di mercanti di schiavi e di generali Stati Confederati d’America abbattute.
I commenti scandalizzati dei media di destra fanno capire che molti hanno l’impressione che l’abbattimento delle statue sia un fenomeno nuovo, almeno nelle metropoli principali dei vecchi imperi coloniali. Ma non è così. Gli Olandesi avevano già cominciato a demolire le statue di Jan Pieterszoon Coen decenni fa.
Guardo con ammirazione i filmati di una protesta a Bristol, in Inghilterra; la quale finisce con il lancio in mare della statua di un mercante di schiavi, responsabile di aver schiavizzato più di ottantaquattromila africani; lo stesso mare dal quale le sue navi avevano salpato. In questa, e nella maggior parte delle analoghe proteste, i partecipanti sono prevalentemente giovani e bianchi.
“Il volersi illudere è esso stesso una componente essenziale della catastrofe che si sta attualmente perpetuando in tutto il Pianeta.”
Assisto alla decapitazione della statua di Cristoforo Colombo e mi torna in mente la furia omicida del secondo viaggio ai Caraibi dell’Ammiraglio, quando le sue truppe “erano sbarcate ed avevano poi ucciso indiscriminatamente, come per sport, qualsiasi animale e uccello e Nativo Americano che incontravano, ‘saccheggiando e distruggendo tutto ciò che trovavano,’ come Fernando, figlio dell’Ammiraglio, ha descritto con inquietante spensieratezza.” Mi ricordo anche che questo viaggio portò il virus dell’influenza nelle Americhe e che Colombo stesso si ammalò, sull’isola di Hispaniola. Mentre era a letto malato, i suoi soldati scatenarono la loro furia omicida la quale, insieme alla malattia, uccise più di cinquantamila isolani. Una volta ripresosi, Colombo “riunì diverse migliaia di truppe armate, la cavalleria e molti cani addestrati all’attacco. L’esercito avanzò occupando la campagna, incombendo sulle masse assembrate di nativi malati e disarmati, trucidandone migliaia alla volta.”
Mosso da un impulso cerco sul web il numero di morti causate dal COVID-19 negli Stati Uniti e scopro che ha superato i 115.000. Scopro anche che, nelle settimane successive all’8 marzo, data in cui ho cominciato l’isolamento a causa della quarantena, più di 570 persone sono state uccise in sparatorie di massa negli USA e che la violenza a mano armata è addirittura aumentata durante il lockdown.
Sono anche affascinato dai filmati di una protesta, organizzata insieme dai movimenti Black Lives Matter e “Rhodes Must Fall”, diretta alla rimozione della statua di Cecil Rhodes da un college dell’Università di Oxford. Il rettorato aveva precedentemente liquidato queste richieste sostenendo che quella statua fosse “una testimonianza delle complessità della storia e dell’eredità del colonialismo” – una posizione assurda, poiché la statua stessa riduce la complessità della storia alla figura di un colonizzatore.
La protesta di Oxford è partecipatissima, molto più del previsto, così come lo sono altre proteste che reclamano la rimozione di statue simili. Ciò sembra confondere alcuni opinionisti, anche i più simpatizzanti, poiché faticano a comprendere come le proteste contro la polizia siano sfociate nella distruzione delle statue. Perché invece non concentrarsi sui “risultati delle politiche”? Perché scomodarsi per dei relitti del passato? Come fa la storia a importare così tanto? Rimuovere una statua, dicono alcuni critici, non cambierà nulla.
Ciò che non vedono è che le lotte riguardo le statue sono lotte di significato e, cambiare il significato che si attribuisce qualcosa, significa cambiare tutto – proprio perché gli esseri umani non sono dei bruti.
A prescindere da ciò che il movimento Black Lives Matter otterrà o meno in futuro, è già riuscito a rendere manifesta la pressante attualità del passato. Ci ha mostrato che l’indifferenza verso la storia, che un tempo era considerata una caratteristica propria della cultura americana, non è altro che un falso mito elitario. I Nativi Americani e gli Afroamericani non sono mai stati indifferenti verso il passato; a maggior ragione poiché hanno dovuto fare i conti con questa violenza sistemica nel loro quotidiano. Ogni protesta è una rivendicazione di come la crisi planetaria affondi le sue radici nel passato e, dunque, di come quest’ultimo sia la lente attraverso la quale è necessario guardarla al fine di comprenderla davvero.
La “Storia”, lungamente utilizzata come strumento di assoggettamento, è straripata fuori dagli argini delle aule di scuola e dei musei ed è dilagata nelle strade. Ironicamente, è lo stesso razzismo insito nella stilatura della Storia, come evidenziava Immanuel Wallerstein, che ne è alla causa.”. Se ormai è diventato impossibile nascondere queste scomode verità, è proprio grazie allo studio approfondito della storia degli Stati Uniti, e delle altre cosiddette “nazioni storiche”. La Storia intesa come cronaca dell’ascesa trionfante dell’uomo occidentale, ha fornito lei stessa la leva per il suo proprio ribaltamento.
Aver visto tutto questo succedere davanti ai miei occhi e nelle strade intorno a me mi commuove e mi lascia sbalordito. Non avrei mai immaginato di vedere qualcosa del genere nel corso della mia vita. È la prova che l’umanità possiede la capacità di rigenerarsi attraverso la comprensione empatica.
SONO seduto alla mia scrivania intento a scrivere riguardo a statue e monumenti, quando sento dei richiami provenienti dalla strada e vedo una protesta di Black Lives Matter che sfila sotto casa mia. Mi precipito fuori per unirmi a loro, e mi ritrovo a camminare, nel mezzo di una folla principalmente di bianchi, verso il monumento che torreggia nel parco di Fort Greene; il monumento dei Martiri della Nave Prigionieri.
Sotto al grido di “Black lives matter!” che echeggia nel parco, leggo la targa vicina al monumento. Mi informa che è stato eretto per commemorare le 11.500 vite di “uomini, donne e bambini” strappate nel 1776, anno nel quale gli Inglesi sottrassero questo territorio all’Armata Continentale di George Washington. Migliaia di prigionieri Americani furono incarcerati sulle apposite navi Inglesi; navi sulle quali morirono per “il sovraffollamento, l’acqua contaminata, la fame e le malattie.”
In quel momento mi viene in mente un episodio della storia Indiana che è “probabilmente tanto conosciuto nel mondo anglofono quanto il fatto che Napoleone fosse l’imperatore di Francia.” Nel 1756, solo vent’anni prima della morte dei Martiri della Nave Prigionieri, 123 prigionieri Inglesi furono dichiarati morti, per il sovraffollamento e l’asfissia, nella prigione Indiana chiamata poi “il Buco Nero di Calcutta”. Questa storia è diventata uno dei “miti fondatori dell’impero” ed è stata utilizzata per secoli al fine di giustificare la violenza degli Inglesi in India.
Ma c’è un problema: non ci sono prove concrete che confermino che questa atrocità sia effettivamente avvenuta. Nel corso di più di un secolo, numerosi studiosi e storici hanno evidenziato che gli indizi a conferma dell’evento sono inconsistenti e che, se il massacro ci fu davvero, allora il numero delle vittime sarebbe meno della metà di quello riportato. Uno di questi studiosi, George W. Hartmann, era professore al Columbia’s Teachers College. Nel 1948, pubblicò un articolo per sfatare questa leggenda. L’articolo comincia sottolineando che:
“Quasi tutti gli adulti istruiti nel sistema anglofono conoscono la storia del Buco Nero di Calcutta; un evento di portata marginale che si suppone sia accaduto nel caldo giugno di quasi duecento anni fa, in corrispondenza della conquista Inglese dell’India. Innumerevoli racconti, più o meno quotati, riportano la breve ma terribile vicenda; perfino le enciclopedie più valide vi appongono il proprio autorevole imprimatur; e, più di recente, anche libri di testo di medicina, ingegneria e psicologia di un certo spessore hanno contribuito, mediante ripetuta citazione, alla diffusione ad ampio raggio di questo episodio.”
I monumenti giocano un ruolo importante nel perpetuarsi della storia. Nel 1902, quando la leggenda del Buco Nero era già stato sostanzialmente smentito, Lord Curzon, il Viceroy dell’India, fece costruire, a sue spese, un monumento commemorativo dell’evento. “Cavalcando fieramente l’ondata del Nuovo Imperialismo,” scrive Partha Chatterjee, “i governatori Inglesi rifondavano così a futura memoria l’idea di un loro passato da vittime d’India.”
Il Buco Nero di Calcutta è diventato così quel frammento della storia della colonizzazione dell’India quasi universalmente conosciuto nel mondo anglofono. A titolo di esperimento, il professor Hartmann ha domandato ai suoi studenti se avessero mai sentito parlare dell’incidente del Buco Nero; dei suoi 115 studenti, circa un terzo ha risposto di sì ed ha affermato di ritenere la storia “sostanzialmente veritiera.” Il professore non ha interrogato i suoi studenti né riguardo ai fatti di Amboyna (scontro anglo-olandese con alcune vittime Inglesi, avvenuto nel 1623 in Indonesia, ndT) né riguardo ai Martiri della Nave Prigionieri. Se lo avesse fatto, immagino che alcuni avrebbero detto di conoscere l’episodio nell’isola di Ambon, ma molto pochi avrebbero invece saputo dire lo stesso riguardo ai 11.500 Americani morti sulle navi prigionieri ancorate al largo delle coste di Brooklyn. Ho scoperto che perfino alcuni storici illustri non sono a conoscenza di quelle morti.
Questo è solo uno dei tanti casi in cui la “Storia”, quella raccontata dai cronisti dell’impero, ha messo in evidenza una vicenda utile ad alimentare la narrazione di vittimismo Inglese bianco, e ne ha oscurata un’altra, ben più sanguinosa, ma inadatta allo scopo. L’Impero, rimarca la storica Priya Satia (nel suo saggio “Empire of Guns”, ndT), “genera e rigenera la pratica stessa della storia.”
LE DEFINIZIONI di chi è il bruto e chi è pienamente umano, e la decisione su chi ha la facoltà di definire il mondo e chi no, stanno al cuore della crisi planetaria.
In questo frangente, alla vista della parabola che ha portato l’umanità sull’orlo di una catastrofe planetaria, siamo obbligati a riconoscere che la nostra attuale condizione è diretta conseguenza del modo in cui certe classi di persone – una piccola minoranza, di fatto – hanno deliberatamente silenziato altre, facendole passare per bruti, per creature la cui presenza sulla Terra è puramente materiale. A causa di questa convinzione, è stato dato per scontato che la maggior parte dell’umanità fosse intellettualmente e culturalmente incapace di svilupparsi industrialmente – e proprio questa illusione di superiorità è una componente essenziale della catastrofe che si sta attualmente perpetuando in tutto il Pianeta.
Il mondo occidentale si sarebbe imbarcato nel bieco sfruttamento di risorse con lo stesso slancio, se avesse immaginato, allora, che un giorno il resto del mondo avrebbe adottato proprio quelle tecniche che hanno permesso ai paesi ricchi di industrializzarsi – esattamente come fece l’occidente stesso, impiegando innumerevoli pratiche e tecnologie non occidentali? Se questa possibilità fosse stata presa in considerazione un secolo fa, allora forse ci si sarebbe preoccupati almeno un po’ delle conseguenze. Eppure nel corso del diciannovesimo e, ancor più, del ventesimo secolo, la classe dirigente si è basata sul pregiudizio implicito che la maggior parte dei non occidentali fossero semplicemente troppo ignoranti, troppo abbruttiti per avviare la transizione industriale su larga scala. Nascosti dietro una terminologia astratta, questi pregiudizi sono stati alla base di una serie di indirizzi accademici come gli studi sullo sviluppo sociale e alcune branche dell’economia e della sociologia, nelle quali la povertà era un attributo “culturale,” un termine spesso carico di razzismo. Questi pregiudizi sono penetrati talmente a fondo in queste discipline da rendere altamente improbabile una loro definitiva estirpazione.
È forse solo negli ultimi due o tre decenni che l’Occidente ha dovuto fare i conti con qualcosa che non aveva mai immaginato possibile: il non Occidente è pienamente capace di adottare politiche economiche basate sull’estrazione e sull’uso intensivo del carbone, insieme a tutto ciò che questo comporta, come la ricerca scientifica e tecnologica, e alcune discipline artistiche e letterari. Se si fosse accettato prima che gli esseri umani sono, e sono sempre stati, creature essenzialmente mimetiche, perfettamente capaci di apprendere l’una dall’altra, allora forse quello della sostenibilità sarebbe stato considerato un problema urgente ben prima. Ma questa possibilità è stata preclusa da quei radicati convincimenti elitari, fino a che i bruti non hanno cominciato a “debrutizzarsi”.
Un’amara ironia vuole che questo processo evolutivo da bruto ad essere umano da parte della classe media dei non occidentali sia avvenuto ripetendo, e addirittura esasperando, il processo inverso, di riduzione degli umani a bruti, che aveva caratterizzato le conquiste coloniali dell’Europa. In India, negli ultimi tre decenni, i credi, le pratiche e mezzi di sostentamento delle popolazioni delle foreste sono finiti sotto attacco come mai visto prima. In una grottesca imitazione degli orribili trattamenti riservati alle popolazioni indigene da parte dei coloni, sempre più foreste sono state sacrificate alle industrie minerarie e del turismo; a volte con il sostegno complice di conservazionisti discriminatori, i quali si schierano a favore della rimozione coatta degli abitanti delle foreste nel nome dell’ecologia. Le montagne sacre a questi abitanti sono state sconsacrate, le loro terre sono state invase da dighe e i loro credi e rituali ridotti a “superstizioni primitive”- esattamente come usavano dire gli amministratori delle colonie, gli scienziati e i missionari dell’epoca. Nel replicare le pratiche dei colonialisti, si è arrivati addirittura togliere i bambini alle loro comunità native, spedendoli in collegi.. Processi simili sono in corso anche in Cina, nei confronti degli Uighur, e in Indonesia, nei confronti dei Papuani.
La differenza sta nel fatto che questo scimmiottamento della brutalità dei colonizzatori non si sono perpetuate nel corso dei secoli, bensì di qualche decennio, a partire dal 1990; e la metà delle emissioni di gas serra che sono ora nell’atmosfera risalgono agli ultimi trent’anni. La vertiginosa accelerazione causata dall’adozione di metodi di estrazione e di consumo di stampo coloniale ha condotto l’umanità sull’orlo del precipizio.
Questo ridotto arco temporale ha fatto sì che anche i bruti non siano più silenti come lo erano un tempo. Altri esseri viventi e altre forze del pianeta – batteri, virus, ghiacciai, foreste, correnti d’aria – si sono anch’esse manifestate, conquistandosi la nostra attenzione con un clamore tale da non poter più essere ignorate o trattate come attributi di una terra inerte.

È ORMAI indubbio, credo, che gli scienziati, filosofi e intellettuali occidentali che sostenevano che i popoli non bianchi fossero, per natura, bruti, insensibili e di fatto muti, si sbagliavano veramente di grosso. E se si fossero sbagliati anche sull’inerzia e sulla materialità bruta di ciò che chiamavano “Natura”? E se i popoli considerati dalle élites occidentale bruti e selvaggi – quegli stessi popoli che riuscivano a vedere vigore, vita e significato in esseri di molte altre specie – avessero avuto ragione da sempre? E se prendessimo sul serio l’idea che la Terra pulluli di altre vite che agiscono, comunicano e raccontano storie, e danno senso al mondo?
E perché dovrebbe sembrarci improbabile? Lo scienziato indiano Jagadish Chandra Bose ha dimostrato tempo fa che le piante possono provare dolore e paura, e persino reagire a determinati stimoli producendo risposte udibili. Il suo lavoro fu ampiamente acclamato per un po’, ma poi gli arbitri della modernità ufficiale hanno colpito e l’hanno messo a tacere, definendolo un “ciarlatano”.
Adesso, però, sono proprio le procedure della modernità ufficiale a svelare le abilità comunicative di molte specie non umane, dai mammiferi marini e gli elefanti, agli alberi e alle foreste. Forse la più nota tra questi scienziati è la celebre primatologa Jane Goodall, che ha descritto episodi di comunicazione con uno scimpanzé che ha chiamato David Greybeard: “i suoi occhi grandi e lucenti, così spalancati…sembravano quasi esprimere tutta la sua personalità. David mi ha insegnato che se lo guardavo negli occhi senza arroganza, senza alcuna pretesa, per lui andava bene… I suoi occhi sembravano quasi finestre attraverso le quali, se avessi saputo come, avrei potuto scrutare la sua mente”.
Oggi sono legittime domande che qualche anno addietro potevano sembrare bizzarre, come quelle che si pone Banu Subramaniam, una botanica studiosa del convolvolo: “nei miei esperimenti con Convulvulus, chi sono i protagonisti? Quale, il ruolo della pianta? Qual è la sua autonomia d’azione? E come influisce la sua storia?”
È ormai accettato scientificamente che gli alberi in una foresta riescono a comunicare tra loro in determinate circostanze – sono in grado di fornire aiuto, sotto forma di carbonio, a membri sofferenti del proprio gruppo; e riescono allertersi a vicenda in caso di pestilenze e malattie. In più, si pensa che alcune piante riescano persino a emettere suoni inudibili all’orecchio umano, ma percepibili da altri esseri viventi. Perciò, solo perché non dispongono del linguaggio – una caratteristica umana – gli alberi sono da considerare muti. Ma poiché gli umani non posseggono l’abilità di comunicare come gli alberi, non potremmo dire che per gli alberi ad essere muti sono gli umani?
Gli umani sembrano convinti che il loro potere distruttivo di alberi e foreste conferisca loro una specie di esclusiva d’azione. L’azione intenzionale, però, può svilupparsi in lassi temporali totalmente differenti. Gli alberi popolano la Terra da molto più tempo degli esseri umani, e la durata della loro vita, molto spesso, è di gran lunga maggiore rispetto a quella umana: alcuni vivono per migliaia di anni. Se gli alberi possedessero raziocinio, i loro pensieri sarebbero calibrati a un arco temporale molto diverso, magari uno in cui è prevedibile che la maggior parte degli esseri umani perirà per una catastrofe planetaria. Dopo un simile avvenimento, il mondo vedrebbe alberi che crescono come mai prima, su terreni ricchi di miliardi di cadaveri in decomposizione. Agli umani potrebbe sembrare ovvio che siano loro i giardinieri, quelli che decidono il destino degli alberi. Ma visto con un’altra lente temporale, diventa altrettanto concepibile che siano gli alberi a coltivare gli umani. Potrebbero essere l’equivalente terrestre di Solaris, il superorganismo oceanico.
O magari le cose non stanno affatto così? Dopotutto, tra alberi e umani non v’è – o quantomeno non soltanto – concorrenza per lo spazio vitale. Sono anche legati da innumerevoli forme di cooperazione. Forse l’errore sta già nel concetto della singola specie. È ormai noto che il corpo umano contiene un vasto numero di micro-organismi di varie tipologie; i biologi stimano che il 90% del nostro corpo sia costituito da batteri, piuttosto che cellule umane, e un microbiologo ha anche affermato che, visto al microscopio, il corpo umano somiglia a una barriera corallina, “un insieme di forme di vita che coesistono”. Sappiamo inoltre che i micro-organismi influenzano l’umore, le emozioni, e la capacità umana di ragionamento. Quindi, se è vero che la facoltà umana di parola, pensiero si manifestano soltanto in presenza di altre specie, quanto possiamo più considerarle appannaggio esclusivo dell’essere umano?
Recenti ricerche in ambito biologico hanno mostrato che molte specie non si evolvono individualmente: i batteri sono essenziali per la sopravvivenza di tutto il regno animale, compresi gli esseri umani. “Sempre più spesso”, afferma un team di biologi, “la simbiosi sembra essere la ‘regola’, non l’eccezione… Sembra che la natura stia selezionando le ‘relazioni’ piuttosto che i singoli individui o i genomi”. Molti organismi nascono sprovvisti dei batteri di cui avranno bisogno per raggiungere la maturità; serve, perciò, che li incontrino nel mondo – e senza questi incontri non possono realizzare a pieno il loro potenziale.
Non potremmo affermare anche di Homo Sapiens, che la presenza di certe altre specie, in determinate occasioni, ci ha permesso di trascendere i nostri limiti? Pensate per esempio a quando il Buddha raggiunse l’Illuminazione, un momento emblematico nella storia della coscienza: è ben noto che questo episodio è avvenuto mentre il Buddha stava meditando sotto un albero della Bodhi. Per più di duemila anni, nella tradizione buddhista, questo albero è inscindibile da quel momento. Questo non per dire che sia l’albero a donare l’illuminazione, né tantomeno che partecipi attivamente a questo processo. E neppure che tutti coloro che meditano sotto un albero della Bodhi raggiungeranno l’Illuminazione.
Eppure, milioni di persone ritengono da tempo che un incontro interspecie, in uno specifico momento storico, è stato fondamentale per l’Illuminazione di un essere umano in particolare, il principe Siddhartha Gautama. Il Buddha stesso credeva che l’albero fosse essenziale affinché raggiungesse l’Illuminazione, motivo per cui, oggi, l’albero della Bodhi è considerato sacro da milioni di persone. Per citare il Dalai Lama:
“Buddha, il Grande Asceta, nacque sotto un albero.
E sotto un albero si assise per attingere il Risveglio, dopo aver vinto le passioni.
Sotto due alberi, poi, entrò nel Nirvana.”
Cosa significa questo? Anzitutto, che alcuni legami tra specie diverse non possono essere compresi con metodi scientifici. Sono incontri, o avvenimenti, che si manifestano in specifici momenti irripetibili. Possiamo avvicinarci a tali incontri solo mediante la storia, attenendoci alle circostanze in cui sono avvenuti.
In secondo luogo, significa che, tra gli esseri umani, è sempre esistita la consapevolezza della possibilità di simili incontri interspecie. Basti pensare a San Francesco d’Assisi e alla storia di come sottomise il lupo mangiauomini di Gubbio. “Frate lupo”, avrebbe detto, “ogni gente grida e mormora di te, e tutta questa terra t’è nemica. Ma io voglio, frate lupo, far la pace fra te e costoro… e né li uomini né li cani ti perseguitino più”. Molti testimoniarono questo incontro, e la tradizione vuole che alla fine i cittadini di Gubbio seppellissero il corpo del lupo in una chiesa intitolata a San Francesco. Cinque secoli e mezzo dopo, nel 1872, durante dei lavori di restauro della chiesa, il corpo di un lupo venne rinvenuto nelle sue fondamenta.
Basta riflettere un istante per rendersi conto che sono tantissimi gli uomini e le donne che affermano di aver comunicato con esseri non umani – animali, vulcani, alberi, divinità, demoni, angeli, e perfino Dio. E nonostante tra coloro vi sia stato un folto numero di impostori o ciarlatani, alcune – come San Francesco – erano tra le persone più venerate del loro tempo: la nostra società e la storia umana sarebbero inconcepibili senza queste figure. Quello che dicevano, però, non può essere compreso o recepito attraverso i modelli di ragionamento odierni, semplicemente perché non può essere replicato o empiricamente verificato. Il modo di ragionare attuale richiede che chiunque affermi di aver comunicato con esseri non umani fornisca le prove di queste interazioni. Questa condizione esclude, per forza di cose, coloro che dicono: “Un essere non umano ha parlato con me, solo con me, solo una volta, mentre ero in uno stato mentale alterato, e quello che mi è stato comunicato non era qualcosa di utile, né verificabile: anzi, era solo una storia.”
Eppure, la maggior parte di queste affermazioni/eventi avviene proprio in questi termini: non sono ripetibili a comando; accadono in circostanze singolari, e spesso in uno stato mentale alterato; e le tracce che lasciano non sono impatti visibili nel mondo reale, ma piuttosto storie, che di volta in volta vengono custodite in libri, iconografie, e riti. La vera domanda, quindi, non è se gli esseri non umani sappiano comunicare e determinare le cose; piuttosto, dovremmo chiederci: Quando, e come è avvenuto che un ristretto gruppo di esseri umani è arrivato a pensare che altri esseri, compresa la maggior parte dei loro simili, fossero incapaci di articolare pensieri e agire autonomamente? Come hanno potuto diffondere, facendone il pensiero dominante della loro era, l’idea che costoro fossero privi di parola, e di mente?
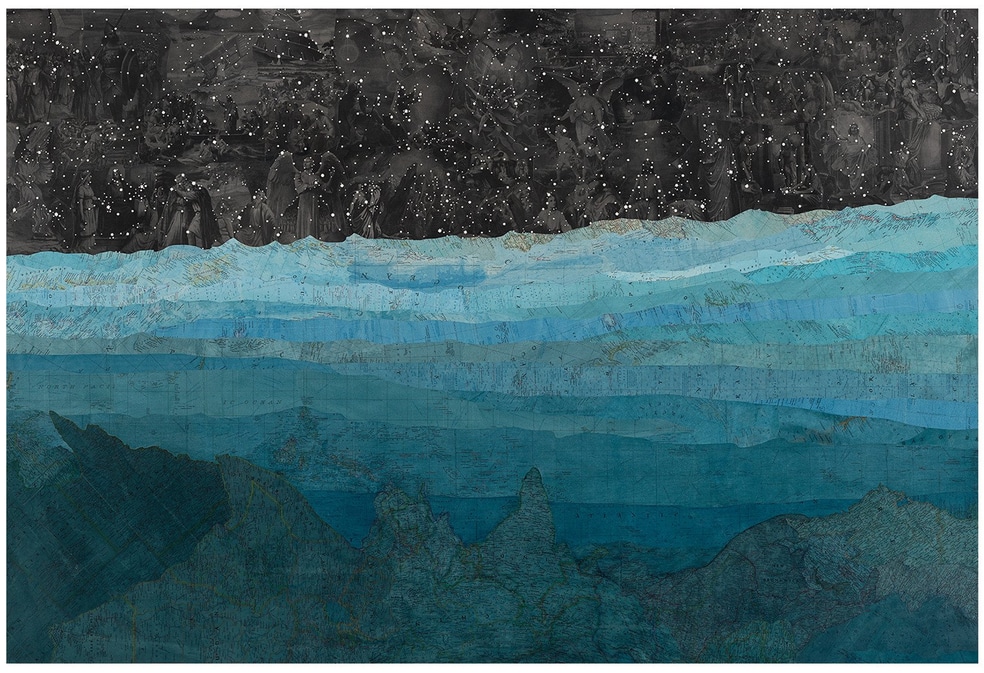
UN PASSO essenziale verso il silenziamento delle voci non umane è stato quello di immaginare che soltanto gli esseri umani sono capaci di raccontare storie. Anche questa idea non trova universale adesione nel tempo; molti, forse la maggior parte delle persone al mondo, ancora non la accettano. Si tratta di un’altra idea elitaria che ha guadagnato terreno con l’affermarsi della metafisica meccanicista. Eppure oggi l’idea che gli esseri umani siano gli unici animali capaci di narrazione sembra indiscutibile, per coloro che ne sono convinti.
Consideriamo, per esempio, questo passo tratto da una delle più belle descrizioni di paesaggio nella letteratura contemporanea, il superbo romanzo di Graham Swift, Il paese dell’acqua, uscito nel 1983. “Solo gli animali” dice uno dei personaggi di Swift “vivono interamente nel Qui ed Ora. Solo la natura non conosce né la memoria né la storia. Ma l’uomo – lascia che ti offra una definizione – è l’animale che racconta storie. Ovunque vada vuole lasciare dietro di sé non una scia caotica, non uno spazio vuoto, ma quelle boe segnaletiche e cartelli segnasentiero che sono le sue storie.“
Questo passaggio fa da epigrafe ad un bell’articolo dello storico dell’ambiente William Cronon. L’articolo tratta la natura della narrazione, e Cronon sostiene che la differenza fondamentale tra una semplice successione di eventi (una “cronologia”) e una storia è che quest’ultima unisce gli eventi in modo da poterli infondere di significato. Questa, secondo lui, è un’abilità specificatamente umana, da cui: “La narrazione è un modo peculiarmente umano di organizzare la realtà.” Quindi, ancora una volta, quello che c’è davvero in ballo non è tanto la narrazione in quanto tale, ma, piuttosto, a chi spetti il potere di produrre significato. Ancora una volta il presupposto è che i non umani non possono infondere, né discernere, il significato delle cose.
“In una diversa scala temporale, potrebbe sembrare altrettanto evidente che gli alberi sono i giardinieri degli esseri umani.”
Così come tanti altri tentativi di definire l’eccezionalità degli esseri umani, questa idea è sostenibile solo se la produzione di significati e la narrazione sono definite in modo circolare, ovvero come se fossero indistricabili dalle forme umane del linguaggio. Ma è davvero così, le esperienze non possono avere alcun significato in assenza del linguaggio? Evidentemente questo non sussiste per gli esseri umani prelinguistici: è ben risaputo che perfino i neonati comprendono, e producono, alcune forme di significato. Quindi perchè dovrebbe essere impossibile collegare differentemente le esperienze in schemi provvisti di significato, attraverso la memoria, la vista, o l’olfatto, per esempio? Chiunque abbia un animale domestico sa che un cane considera significativa la relazione tra la casa, il parco e alcuni momenti della giornata. Per il cane, si tratta di una “cronologia” o una “narrazione”? In entrambi i casi, è chiaro che il cane non vive “interamente nel qui ed ora”; le sue esperienze sono consequenziali e comprese nel loro sviluppo spaziale e temporale
L’importanza della messa in sequenza è evidente a chiunque abbia mai provato a scrivere una storia: una narrazione altro non è se non una disposizione ordinata di una sequenza di eventi. Questo è il motivo per cui le frasi che collegano un paragrafo all’altro sono di vitale importanza: forniscono le connessioni sequenziali tra eventi e luoghi da cui emerge una narrazione significativa. Questo tipo di ordinamento in sequenza narrativo è analogo al movimento attraverso il tempo, così come attraverso lo spazio: è esattamente questo che si intende con il termine “dispiegarsi” della storia. Questo potrebbe spiegare perché così tante tra le narrazioni più antiche e più potenti al mondo sono storie che si sviluppano attraverso il movimento: per esempio, il Ramayana, l’Odissea, le saghe norrene, Viaggio in Occidente e tante altre.
È ormai assodato che molti animali hanno una lunga memoria e sono in grado di comunicare in modi complessi. Alcuni di questi animali, come gli elefanti, le balene e gli uccelli migratori, si spostano anche su distanze immense e sembrano essere legati a luoghi specifici. Questi movimenti non possono essere descritti come puramente meccanici, istintivi o privi di sequenze provviste di significato. Le megattere, per esempio, segnano il passaggio del tempo cambiando il loro canto di anno in anno. Questo sarebbe difficilmente possibile se vivessero “interamente nel Qui e Ora”.
Già negli anni ‘30, il biologo Jakob von Uexküll dimostrò che molti animali interpretano in maniera attiva l’ambiente circostante, creando dei loro propri mondi esperienziali. Questa idea è da sempre avversata da coloro che vedono nell’attribuzione di qualità umane agli animali un errore cardinale. Ma, come Eileen Crist ha dimostrato in modo convincente nel suo libro Images of Animals: Anthropomorphism and Animal Mind, il rigido rifiuto dell’antropomorfismo non fa che aumentare il rischio dell’altrettanto fallace e correlato meccanomorfismo – l’assunto che gli animali siano creature simili alle macchine che non possono, in linea di principio, essere dotate di una mente o di facoltà interpretative.
In breve, ci sono molti validi motivi per concludere, così come fa Donna Haraway, che “raccontare storie non può essere più una prerogativa dell’eccezionalismo umano.” L’antropologo Thom van Dooren va oltre. In un affascinante studio su uno stormo di pinguini che ritornano ostinatamente, anno dopo anno, sulle rive di un sobborgo di Sydney, conclude che l’attaccamento degli uccelli al luogo nasce dal loro “narrare”. Scrive: “anche esseri legati alla propria esperienza come i pinguini ‘rappresentano’ il mondo a sé stessi: non prendono semplicemente i dati sensoriali come fenomeni non filtrati e privi di significato, ma compongono il significato a partire dalle esperienze, così che anche loro, come gli esseri umani ‘abitano in un mondo fatto continuamente di storie’.”

Vediamo così che l’idea degli esseri umani come unici animali narratori non sia affatto un ritratto della realtà privo di screzi. È qualcosa che alcuni preferiscono credere, proprio come un tempo alcuni credevano che la maggior parte degli esseri umani fossero dei bruti e, per questo, incapaci di costituire significati. Si tratta, in altre parole, di un costrutto che è intimamente legato alle strutture di potere e alla violenta repressione della consapevolezza dell’autonomia di azione ed espressione propria dei non umani. Non sorprende che, anche in questo caso, la mano del potere sia spesso caduta più pesantemente sulle popolazioni Indigene.
Quando oggi pensiamo alla repressione delle storie, le nostre menti saltano immediatamente alla letteratura dissidente e ai regimi autoritari. Tuttavia, anche altri tipi di storie sono state soppresse, o represse, per motivi piuttosto differenti e per periodi molto più estesi – per esempio, le narrazioni hummahhah dei Pueblo di Laguna. Nelle parole di Marmon Silko, queste storie parlano dei discorsi che “i coyote, i corvi e le poiane intrattenevano con gli esseri umani”. Nella sua autobiografia, Turquoise Ledge, Silko ricorda come, nella sua infanzia, le storie hummahhah non potevano essere menzionate in determinati spazi pubblici poiché rivelavano “la visione spirituale dei Laguna verso gli animali, le piante e gli spiriti.” Le storie persistevano nell’ombra, come una tradizione segreta.
È del tutto possibile, allora, che, lungi dall’essere un attributo esclusivamente umano, la facoltà narrativa sia la più animale delle capacità umane, il prodotto di uno dei tratti che l’uomo condivide indiscutibilmente con gli animali e con molti altri esseri: l’attaccamento al luogo. Forse, allora, l’atto di raccontare storie, lungi dal distinguere gli esseri umani dagli animali, è in realtà il più importante residuo delle nostre originarie identità silvestri. Questo spiegherebbe perché le storie, più di ogni altra cosa, sono la quintessenza del dominio della vita immaginativa umana in cui i non umani avevano voce, e dove l’autonomia non umana era pienamente riconosciuta e persino celebrata. Fare questo salto può essere difficile in altri domini di pensiero più prosaici, ma non era affatto una forzatura nel mondo della narrazione, nel quale tutto è possibile.
Il restringimento delle possibilità in questo ambito, e la conseguente cancellazione delle voci non umane dalla letteratura “seria”, ha contribuito non poco a creare quella cecità verso gli altri esseri che è una caratteristica così marcata della modernità ufficiale. Ne consegue, quindi, che se queste voci non umane devono essere riportate allo stato che a loro spetta, questo deve accadere, in primo luogo, attraverso il mezzo delle storie.
È questo il grande fardello che oggi grava su scrittori, artisti, registi e tutti coloro che operano nella narrazione di storie: a noi spetta il compito di restituire immaginativamente autonomia e voce ai non umani. Come tutte le più importanti imprese artistiche nella storia umana, questo compito è allo stesso tempo estetico e politico – e a causa dell’enormità della crisi che affligge il pianeta, è adesso caricato della più pressante urgenza morale.
Estratto da The Nutmeg’s Curse, in uscita in traduzione per Neri Pozza nel 2022.
Amitav Ghosh è nato a Calcutta nel 1956, ha studiato a Oxford e attualmente vive tra la sua città natale e New York. Considerato «uno dei più grandi scrittori indiani» (la Repubblica), per Neri Pozza ha pubblicato: Il paese delle maree (2005), Circostanze incendiarie (2006), Il Palazzo degli specchi (2007), Mare di papaveri (2008), Il cromosoma Calcutta (2008), Lo schiavo del manoscritto (2009), Le linee d’ombra (2010), Il fiume dell’oppio (2011), Diluvio di fuoco (2015), La grande cecità (2017) e Jungle Nama (2021).
”Brutes – Meditations on the myth of the voiceless” https://orionmagazine.org/article/brutes/
© 2021 Amitav Ghosh. All rights reserved.
Testo per gentile concessione dell’autore; traduzione di Chiara O., Claudia D.L., Ilenia V., Lara C. e Valeria B. di FFF Italia.
Illustrazioni per gentile concessione di Matthew Cusick https://www.mattcusick.com
